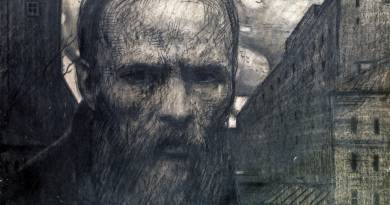“Nomadland”, il canto della terra nomade
Nomadland (2020) di Chloé Zhao rappresenta, mediante una indubbia forza visiva, una caratteristica peculiare della società contemporanea, il nomadismo, un vero e proprio fenomeno sociale che appare quasi come una risposta alla massificazione imperante. Il nomadismo si configura inoltre come una metafora per una nuova idea di soggettività, sostituendosi a concetti paralleli ma meno radicali come cosmopolitismo, apolidia, esilio. Ad esempio, nella teoria femminista di Rosi Braidotti appare la pregnante metafora di un Soggetto nomade (definito, più che dall’atto del viaggiare, dal ribaltamento delle convenzioni date): mobile, multiplo, ibrido, generatore continuo di un’estetica nomade basata sulla transdisciplinarità e sulla mescolanza di stili. Del resto, una sistemazione teorica del concetto di nomadismo era già stata offerta all’inizio degli anni Ottanta da Deleuze e Guattari in Mille Piani, in cui gli studiosi avevano sottolineato la presenza di una “macchina da guerra nomade” che, giunta dallo spazio “liscio”, non sottoposto alle griglie del controllo, attacca il cittadino spazio “striato”, sedimentato dalle dinamiche della sorveglianza e del controllo, nonché dagli stereotipi delle convenzioni sociali. Nomade è infatti Dioniso, il dio del teatro che, giunto da Oriente, nelle Baccanti di Euripide semina scompiglio a Tebe; nomade è, se vogliamo, anche il vampiro in Dracula di Bram Stoker e nelle successive trasposizioni cinematografiche, misterioso personaggio che giunge da inquietanti lande orientali per attaccare Londra, il cuore del capitalismo occidentale.
La sessantenne Fern, protagonista del film, interpretata da una bravissima Frances McDormand, dopo aver perso il marito e il lavoro durante la Grande Recessione che, a partire dal 2006, devastò gli Stati Uniti, percorre gli stati occidentali a bordo del suo furgone, che è diventato ormai la sua unica casa. E se nel film, il suo nomadismo diviene anche una metafora della condizione esistenziale dell’individuo contemporaneo, costretto a passare da un lavoro all’altro in brevi periodi di tempo (Fern lavora per qualche mese da Amazon, poi come inserviente in un parco turistico, poi torna a lavorare da Amazon), appare anche come un vero e proprio canto elegiaco del territorio americano. La terra, infatti, è assai presente nel film, nei suoi diversi aspetti. Terra come sassi, sabbia, ghiaia ma anche terra come territorio. I sassi sono estremamente presenti nel film e la stessa protagonista viene inquadrata dalla macchina da presa mentre cammina solitaria in una cava, nel parco minerario dove Dave lavora come guida. Ed è proprio un sasso, inoltre, ad apparire quasi come l’estremo pegno d’amore offerto da Dave a Fern prima della sua partenza. Il territorio è poi, forse, il vero protagonista del film: il Nevada e gli Stati Uniti occidentali, lande desertiche, montagne sullo sfondo, strade ghiacciate e innevate, spazi sconfinati sui quali si stagliano incantevoli tramonti, bellezza inesprimibile che lambisce col suo roseo tocco le reali crudeltà che attanagliano l’esistenza degli individui. Il furgone di Fern (il “van” che lei ha chiamato “Vanguard”) percorre gli immensi spazi in una erranza incessante, in una spinta a nuovi incontri e scoperte che però non possiede la carica positiva presente, ad esempio, nelle opere di Kerouac. L’on the road di Fern non ha in sé la spinta generativa verso il nuovo, riscontrabile nelle opere dello scrittore della beat generation: è semmai un ripiegarsi verso le proprie ansie e la propria, insondabile, anaffettività, canto del cigno di una generazione nomade e contestataria sullo sfondo di un territorio che possiede ben radicata in se stesso l’impronta del nomadismo.
Quest’ultimo – oltre che metafora di una condizione lavorativa sempre più precaria e sempre più incerta e indefinita, dominata da un capitalismo avanzato che, sulle macerie del lavoro, prosegue il suo cammino come un macabro zombie – diviene anche la metafora della condizione affettiva degli individui contemporanei. L’instabilità lavorativa, gli spostamenti continui portano inevitabilmente anche a una precarietà degli affetti. Come unico rimedio alla propria solitudine esistenziale, Fern sembra aver trovato una ideale condizione di anaffettività che la tiene a distanza da ogni coinvolgimento emotivo con gli altri. Così è con Swankie, simpatica viaggiatrice che sogna di raggiungere l’Alaska, stroncata da un male incurabile che le cova dentro ma così è, soprattutto, con Dave, il quale si illude di aver ritrovato una compagna a cui stare vicino all’ombra dei suoi affetti familiari. Fern, invitata da Dave a rimanere con lui e con la famiglia di suo figlio, non riuscirà a riconoscersi in una esistenza stanziale e abbandonerà la casa, sicura e accogliente, che in una inquadratura dall’alto può ricordare la casa paterna di Solaris (1972) di Andrej Tarkovskij, completamente avvolta dal magma dell’oceano pensante del pianeta Solaris. Così, la villetta della famiglia di Dave è avvolta da un territorio che è esso stesso nomade, metafora e corporea presenza di una condizione esistenziale che non lascia scampo: come l’oceano tarkovskijano, anch’essa avvolge e ingloba, divora la mente, occupa i corpi. Fern deve abbandonare la casa, richiamata da quel territorio nomade che alto leva il suo canto, che intona il suo meraviglioso e crudele richiamo. E, per lo stesso motivo, la donna non riesce neanche a fermarsi nella casa della sorella, anch’essa calda e accogliente ma immagine di una inesorabile rinuncia al nomadismo interiore da cui ella appare avvolta.
Anaffettiva con gli esseri umani, Fern sembra legata in modo speciale a quella terra, al territorio e alla natura. Il suo corpo appare perfettamente inglobato nei paesaggi ferrigni e terrosi delle cave ma anche nella liquidità avvolgente dei torrenti di montagna, solcati dal suo corpo nudo con una ferinità probabilmente sconosciuta agli ‘stanziali’, gli abitatori dello spazio “striato” cittadino. Ella si configura come una figlia delle estreme lande americane, lontane dal processo di tecnologizzazione e occidentalizzazione, come i due indiani Sioux Lakota mostrati da Chloé Zhao nel suo primo lungometraggio Songs My Brothers Taught Me (2015) o il cow boy del suo secondo film, The Rider – Il sogno di un cowboy (2017).
Insieme a lei, altri nomadi percorrono gli immensi territori occidentali: per scelta, come Fern, oppure costretti dagli imprevisti della vita, questi nipoti dei beat di Kerouac (anche se alcuni potrebbero quasi essere quegli stessi personaggi di On the Road ormai invecchiati, feriti dalla vita e disincantati) si muovono su camper, furgoni e automobili per ritrovarsi in veri e propri campeggi auto-organizzati. E se il loro vagare assomiglia di più al sordido vagabondaggio senza via d’uscita che avvolge il protagonista del Viaggio al termine della notte di Céline, pure, in essi continua a sopravvivere il recondito desiderio di liberazione dalle dinamiche di una società che riduce gli esseri umani ad automi. Il viaggio continua e, con il viaggio, continuano a sopravvivere anche le possibilità di liberazione. Rifiutando di ‘stanziarsi’, probabilmente, Fern insegue fino in fondo un processo di rifiuto della meccanizzazione dell’esistenza; allora, il nomadismo si può configurare per certi aspetti come una pulsione veramente antagonista, una condizione esistenziale, certo non facile, diretta verso inediti e inesplorati percorsi di liberazione.
Guy van Stratten